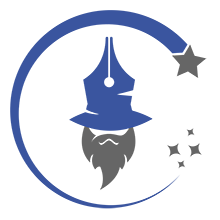- userLoginStatus
Welcome
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please disable your ad blocker to continue.
Aerospace engineering - Elementi di ingegneria aerospaziale II
Impianti combustibile
Divided by topic
IMPIANTO COMBUSTIBILE =NTRODUZ=ONE: SCOPO E COMPONENT= L'impianto combustibile ha lo scopo di stivare il combustibile e di portarlo ai motori nelle condizioni di pressione e di portata richieste dal motore e nella quantità (V) necessaria per la missione (compresa riserva di sicurezza) . =noltre il trasferimento di combustibile tra i serbatoi contribuisce al centraggio del velivolo. Man mano che viene consumato il combustibile il velivolo potrebbe sbilanciarsi e diventa quindi importante compensare. = componenti principali dell’impianto sono: - i serbatoi; - le tubazioni e relative valvole; - le pompe di trasferimento e di alimentazione; - il sistema di rilevamento della quantità di combustibile ( sistema di misura) ; - = filtri; - =l sistema di rifornimento e svuotamento; Le specifiche di progetto di un impianto combustibile prescrivono, oltre alla quantità di combustibile da trasportare, la portata e la pressione necessarie ai motori in varie condizioni di volo, di quota e di temperatura. =noltre l’impianto deve essere progettato in modo che possa alimentare tutti i motori anche in caso di avaria di una parte del sistema di alimentazione. MOTOR= UT=L=ZZAT= =n campo aeronautico : ‣ Motori alternativi ‣ Motori alternativi ad iniezione ‣ Turboreattori =n campo spaziale : ‣ Endoreattori (motori a razzo) ‣ Propulsori speciali PARTE A: AERONAUTICA MOTOR= ALTERNAT=V= A CARBURATORE =l carburatore è un elemento meccanico dei motori a scoppio posto nell'impianto di alimentazione che ha lo scopo di miscelare carburante e aria da immettere nella camera di combustione del motore. Miscela benzina -aria formata nel carburatore : =l carburante viene raccolto in una vaschetta e mantenuto a livello costante tramite un galleggiante . (il galleggiante governa uno spillo che fa affluire più o meno benzina nella vaschetta aprendo delle feritoie, in modo da avere un livello costante di benzina ) L’aria esterna viene aspirata dai cilindri tramite il tubo di Venturi formando una corrente d’aria che, per effetto Venturi, provoca una depressione . Grazie a questa depressione il carburante viene aspirato dalla vaschetta all’interno del condotto e nebulizzato . Avviene dunque la miscelazione aria/carburante . La miscela andrà poi a essere combusta all’interno della camera di combustione. La portata di aria viene controllata tramite una valvola, normalmente a farfalla, e la percentuale di carburante viene mantenuta quasi costante. Nei carburatori più evoluti quest’ultima puo essere regolabile. Per l’avviamento del motore é previsto un arricchimento della miscela. MOTOR= ALTERNAT=V= A =N=EZ=ONE L'iniezione è un sistema di alimentazione che permette, ad esempio, di polverizzare il combustibile nei motori a combustione interna, tramite l'utilizzo di un iniettore comandato da un'apposita centralina ECU che modifica la fasatura d'accensione. La regolazione del combustibile iniettato avviene dunque tramite un sistema elettronico che controlla anche accensione e anticipo. L’iniezione si pone in alternativa alla nebulizzazione per carburazione (nebulizzazione automatica) . Funzionamento : ‣ Q aria regolata da valvola (normalmente a farfalla) ‣ Carburante ad alta pressione iniettato in quantit à calibrata nel condotto di aspirazione subito a monte della camera di combustione MOTOR= A GETTO = turbofan sono i più utilizzati, essi sono infatti più eficienti dei classici turbogetti. La parte centrale di un motore a getto é composta da compressore, camera di combustione con iniettori a cherosene e turbina. CONTROLLO MOTORE La p ortata di combustibile può essere molto bassa se si viaggia a regime minimo e viceversa alta in caso di regime elevato (es. richiamata d’emergenza, decollo) . Fino a decine d’anni fa il controllo era completamente manuale (lo é ancora in alcuni velivoli di aviazione generale ) → il pilota muovendo la leva va a muovere valvola che dosa portata di combustibile . Erano infatti in tre 3 in cabina di pilotaggio, 2 piloti e il flight engineer che doveva occuparsi della gestione degli impianti . Oggi il controllo del motore viene effettuato tramite FADEC . Di fatto il sistema ad oggi é un fly -by -wire. FADEC utilizza la lettura di parametri di altitudine, temperatura, pressione per effettuare il controllo. Aspetti principali : ‣ Efficienza ‣ Affidabilit à (ridondanza) ‣ Protezione da funzionamenti fuori regime ‣ Precisione impostazione spinta da FMS ‣ Avviamento automatico ( un tempo tutti i passaggi venivano fatti da pilota) ‣ =ntegrazione con gli altri sistemi – controllo del volo, uscita da stallo ( semplice perché fly -by -wire) ‣ Monitoraggio e diagnostica – meno informazioni a equipaggio Trasmette periodicamente con una frequenza di qualche secondo segnali alle case costruttrici in modo che possano operare rapidamente in caso di anomalie . =l pilota non può intervenire direttamente sul malfunzionamen to. D=SPOS=T=V= AUS=L=AR= =l propulsore ha calettato su di esso alternatore, avviatore, pompe idrauliche, electrical generator, per “rubare” un po’ di potenza ad esso . Sistema di lubrificazione interno a sistema : CONSUM= MOTOR= ALTERNAT=V= Dati generali : ‣ Carburante: benzina ‣ Consumo specifico: 220 – 400 (g/h)/kW ‣ Densit à: 735 kg/m3 es.: Piper AZTEC ‣ 2motori da 250 CV = 190 kW ‣ Portata a 1 motore 100 l/h = 2.78 ⋅10 -5 m3/s ‣ Velocit à nei tubi 1 m/s => sezione 2.78 ⋅10 -5m2 = 27 mm2 => D = 6 mm ‣ Autonomia 1320 nm a 150 kts, 530 l / 390 kg Una velocità nei tubi troppo elevata può portare a problemi di perdite. CONSUM= TURBOEL=CA Dati generali : ‣ Carburante: kerosene ‣ Consumo specifico : 230 g/CV/h ‣ Densit à 750 kg/m3 es.: Loockeed Hercules C -130 ‣ 4motori da 5000 CV ‣ Portata a 1 motore 1150 kg/h = 1.5 m3/h = 0.4 ⋅10 -3 m3/s ‣ Velocit à nei tubi 1 m/s => sezione 0.4 ⋅10 -3 m2 = 400 mm2 => D = 22 mm ‣ Autonomia (ferry range) 4000 nm a 290 kts, 32000 kg / 43 m3 CONSUM= TURBOGETTO Dati generali : ‣ Carburante: kerosene ‣ Consumo specifico 0.017 kg/kN/s ‣ Densit à 780 kg/m3 es.: Boeing 747 ‣ 4motori da 280 kN ‣ Portata singolo motore = 22 m3/h = 6.1 ⋅10 -3 m3/s ‣ Velocit à nei tubi 1 m/s => sezione 6.1 ⋅10 -3 m2 => D = 88mm ‣ Autonomia 7300 nm a 480 kts, => 169000 kg => 217 m3 SPEC=F=C:E =MP=ANTO COMBUST=B=LE Alimentazione : ‣ Richiesta di Q carburante = funzione del regime di funzionamento ‣ Motori alternativi a iniezione, turboelica e turboreattori dotati di pompa interna che ne governa il funzionamento ‣ Pompa esterna deve garantire che il carburante arrivi al motore nelle corrette condizioni di p e T in tutto l’intervallo di Q Volume, portata e pressione : ‣ V di combustibile da imbarcare ‣ Q min e max ‣ Campo di p ammesse all ’ingresso motore COLLOCAZ=ONE SERBATO= Le quantità di combustibile trasportate a bordo di alcune classi di velivoli raggiungono dei valori molto elevati e costituiscono una percentuale sensibile del peso a pieno carico del ve livolo. % COMBUST=B=LE R=SPETTTO MTOW Problemi legati al trasporto : ‣ Diminuire carico strutturale sull ’ala → combustibile nell’ala si distribuisce e va a controllare il momento dovuto alla portanza (controproducente per aerei acrobatici) ‣ Limitare spostamenti CG durante consumo Risulta così importante studiare la corretta posizione di stivaggio del combustibile dato che il suo consumo, se procura variazioni sensibili della posizione del baricentro, può avere una notevole influenza sul centraggio del velivolo; un corretto posizion amento del combustibile tiene quindi conto dei volumi disponibili a bordo del velivolo, in modo da lasciare il massimo spazio possibile ai carichi paganti, ma non può prescindere dai problemi di centraggio. Una delle collocazioni maggiormente utilizzate p er stivare il combustibile è costituito dall'ala; in questo modo si impiega un volume scarsamente utilizzabile per altri scopi, si colloca il centro di massa del combustibile in prossimità della posizione longitudinale del baricentro del velivolo e si ha l 'effetto di produrre una diminuzione del carico sull'ala. La soluzione tipica degli attuali velivoli da trasporto passeggeri è con serbatoi alari ed eventualmente centrali nella zona della radice alare. Sono a volte usate anche configurazioni con serbatoi ricavati negli impennaggi di coda, configurazioni utilizzate per controllare il centraggio mediante trasferimento di combustibile. Lo stivaggio solo in fusoliera viene utilizzato principalmente nei velivoli con ala di basso spessore (come spesso accade nei velivoli supersonici), dove il volume interno dell'ala stessa sarebbe troppo ridotto per poter essere efficacemente utilizzato. Oppure quando si vuole garantire un’elevata manovrabilità in rollio, riducendo il corrispondente momento d’inerzia (aerei acrobatici) . =n alcuni casi per mantenere il centraggio del velivolo si attivano pompe di trasferimento del combustibile tra i vari serbatoi. Tali pompe sono anche utilizzate per inviare combustibile dai serbatoi secondari a quelli primari, che sono i serbatoi di racco lta ed alimentazione dei motori. T=POLOG=E D= SERBATO= = serbatoi utilizzati per il trasporto del combustibile possono essere di diversi tipi: - Rigidi : collocati ove esistano vani idonei o all ’esterno del velivolo(fusoliera) - Flessibil i: sacche alloggiate e opportunamente contenute e vincolate entro vani appositi - Integrati : parte della struttura, peso contenuto, necessit à di renderli stagni (ad ala) SERBATO= R=G=D= Caratteristiche : ‣ Serbatoi di estremit à alare ‣ Serbatoi subalari, a volte da montare solo per voli di trasferimento ‣ Serbatoi per piccoli velivoli o elicotteri = serbatoi rigidi, utilizzati nell'interno delle fusoliere, hanno il vantaggio di costituire un componente isolato, indipendente dalla struttura, con la quale interferiscono solo attraverso gli attacchi. D'altra parte hanno peso superiore a quello delle al tre soluzioni e può essere problematica la loro installazione nell'interno della struttura e l’eventuale smontaggio per manutenzione. L’impiego dei serbatoi rigidi è principalmente costituito dai serbatoi esterni, come i serbatoi di estremità alare o i serbatoi ausiliari utilizzati nei velivoli da combattimento per i voli di trasferimento o comunque quando è richiesta un’elevata autonomi a. Sebbene il vantaggio del combustibile aggiuntivo venga in parte perso dall’aumento della resistenza aerodinamica, questi serbatoi vengono di solito appesi sotto l’ala, in casi meno frequenti sopra l’ala o sotto la fusoliera e solitamente sganciati in ca so di combattimento. SERBATO= FLESS=B=L= = serbatoi flessibili sono serbatoi di materiale sintetico, non attaccabile chimicamente dal combustibile, montati in un vano e fissati attraverso un certo numero di punti di attacco. = serbatoi flessibili consentono un certo movimento rispetto alla strutt ura e quindi non interferiscono con la rigidezza strutturale; d'altra parte, proprio per questa possibilità di movimento, possono avere dei problemi di usura. Può inoltre risultare difficile il montaggio nel loro interno dei componenti dell'impianto. = serbatoi flessibili sono composti da s acche che seguono la deformazione della struttura , dunque tendono a non subire lacerazioni in caso di un atterraggio di emergenza . Un altro vantaggio é che evitano la stagnatura di alcuni vani ( ad esempio quelli in cui passano circuiti elettrici), che risulterebbe altrimenti complicata. SERBATO= ALAR= =NTEGRAT= Vantaggi: ‣ Utilizzo di volume gi à disponibile ‣ Baricentro serbatoi vicino baricentro velivolo ‣ Riduzione carico alare Svantaggi: ‣ Aumento del momento d ’inerzia di rollio ‣ Scarso volume disponibile nei supersonici (hanno le ali sottili) ‣ Ampia superficie esposta ai proiettili (militari) = serbatoi integrali, impiegati principalmente nelle ali, sono ricavati dalla struttura stessa, sigillando completamente il vano utilizzato a tale scopo. La soluzione è vantaggiosa dal punto di vista del peso . Richiede alcuni accorgimenti nella realizzazione per il montaggio e la manutenibilità dei componenti dell'impianto installati nell'interno del serbatoio. =l serbatoio deve contenere un certo numero di componenti dell'impianto combustibile: bocchettoni di rifornimento, paratie anti -sbattimento, sfiati, filtri, pozzetti di drenaggio, pompe ausiliarie, misuratori di livello. ARC:=TETTURA =NTERNA DE= SERBATO= Nell'interno dei serbatoi, soprattutto se questi hanno dimensioni notevoli, è necessaria la presenza di paratie anti -sbattimento (centine) , in grado di smorzare le oscillazioni del combustibile indotte dal movimento del velivolo. Normalmente i più grossi problemi di questo tipo si hanno in serbatoi molto allungati quali i serbatoi alari; un serbatoio alare con forte allungamento è normalment e un serbatoio alare integrale e quindi comprende nel suo interno un certo numero di centine che possono essere sufficienti a smorzare le oscillazioni del combustibile. Spesso, in condizioni di questo tipo, i fori di alleggerimento delle centine e di passaggio dei correnti, che vengono utilizzati per consentire il passaggio del combustibile dall'uno all'altro settore del serbatoio, sono dotate di valvole di non ritorno a flabello (baffle valves) che tendono quindi a radunare il combustibile verso la mezzeria dove è posto il pozzetto di raccolta (diminuendo così il momento di inerzia) . = serbatoi devono essere dotati di sfiati in grado di assicurare la necessaria ventilazione durante l'impiego e lo sfogo dell'aria durante il rifornimento. Spesso i serbatoi vengono pressurizzati, inviando aria dal sistema pneumatico, in modo da limitare l e perdite per vaporizzazione e diminuire il rischi di cavitazione delle pompe combustibile. Nella parte inferiore del serbatoio è ricavato un pozzetto di raccolta dal quale, dopo un filtro, parte la tubazion e di mandata del combustibile. La presa del combustibile è ricavata in modo da non pescare direttamente dal fondo. Questo consente di radunare nel fondo del pozzetto impurità presenti nel combustibile ed eventuali condense dell'acqua; è così possibile prov vedere nella parte inferiore del pozzetto a prese di drenaggio. Nei velivoli acrobatici con motore a reazione il pozzetto deve avere la possibilità di chiudersi in volo rovescio in modo da costituire una piccola riserva in grado di assicurare l'alimentazio ne dei motori per tutto il tempo del volo rovescio. La presa dal pozzetto è normalmente dotata di una pompa; questa, nei serbatoi ausiliari deve assicurare il travaso ai serbatoi principali; nei serbatoi principali invece è utilizzata per assicurare all’ingresso dei motori una corretta pressione. PUL=Z=A E F=LTRAGG=O =ntroduzione di valvole di drenaggio nei serbatoi e vari filtri lungo le linee per: ‣ Acqua (formazione di ghiaccio) ‣ Ossido e altre impurit à (malfunzionamento pompe e iniettori) ‣ Micro -organismi (modifica delle caratteristiche del combustibile, corrosione) ARC:=TETTURA DEL S=STEMA D= SERBATO = La struttura classica di un impianto combustibile è costituita da linee di alimentazione separate per i singoli motori, ognuna delle quali comprende un serbatoio principale ed eventualmente un serbatoio secondario, possono essere inoltre presenti serbatoi ausiliari che travasano nei principali. = motori sono normalmente alimentati dal serbatoio principale, mentre il serbatoio secondario travasa nel principale. =n caso di necessità però é possibile alimentare il motore direttamente dal serbatoio secondario, eventualemente con prestazioni minori. Nel caso di plurimotori, è sempre prevista la possibilità di alimentazione incrociata; in caso di emergenza si deve poter alimentare qualsiasi motore partendo da qualsiasi serbatoio. R=FORN=MENTO Riempimento : ‣ Durante riempimento: espulsione aria o vapori contenuti nel serbatoio attraverso valvole di sfiato ‣ Riempimento incompleto per lasciare un certo margine per espansioni termiche ‣ A riempimento ultimato, chiusura linee di sfogo dell’aria e eventuale leggera pressurizzazione per favorire l’alimentazione delle pompe e diminuire la tendenza ad evaporare del combustibile A terra , in zona subalare: ‣ Carico da esterno (autocisterna o linee a terra) in pressione (~0.35 MPa) attraverso un ingresso centralizzato e una rete di distribuzione ‣ Pannello di controllo per la quantit à totale e la ripartizione ai vari serbato i A seconda del tipo di impianto e delle possibilità fornite dai servizi a terra, il riempimento può avvenire per gravità o con invio di combustibile sotto pressione. L'invio di combustibile pressurizzato è di solito centralizzato, nel senso che esiste un pa nnello di rifornimento, accessibile da terra, attraverso il quale si comanda il riempimento dei vari serbatoi. Per impianti di velivoli leggeri con serbatoi di bassa capacità il riempimento può avvenire per gravità da bocchettoni posti nella parte superior e del serbatoio; questo è impensabile nei velivoli di dimensioni maggiori con impianti complessi, dove è previsto il rifornimento pressurizzato da un unico o più pannelli. =l rifornimento può provenire da autobotti o da impianti aeroportuali fissi in corri spondenza delle piazzole di sosta. =n ogni caso occorre collegare elettricamente il velivolo e la sorgente di rifornimento in modo da evitare la possibilità di formazione di archi elettrici per differenze di potenziale elettrostatico; è quindi necessario provvedere a opportuni collegamenti elettrici di terra fra i vari componenti. Dato che il riempimento in pressione avviene con portate rilevanti è necessario che durante il rifornimento sia assicurato lo sfiato dell’aria contenuta nei serbatoi; terminato il rifornimento viene mantenuto una linea di ventilazione per assicurare l’entrata di aria durante il consumo del combustibile e per compensare variazioni di volume del combustibile legate a variazioni di temperatura. =l serbatoio viene inoltre spesso leggermente pressurizzato. = bocchettoni di riempimento devono essere installati in modo che sia impossibile riempire completamente i serbatoi, ma che resti un certo volume di espansione in modo da compensare eventuali dilatazioni del combustibile per variazione delle condizioni amb ientali. SEQ UENZA D= R=EMP=MENTO Si comincia da serba toi alari, mentre per ultimi vengono riempiti fusoliera , semilali e impennaggi in coda. SEQUENZA D= CONSUMO = serbatoi alari vengono tenuti pieni per una buona parte della navigazione, con un andamento irregolare (continuano a rabboccare center tank).Quando il center tank si svuota, si iniziano a consumare quelli alari. = serbatoi di coda vengono tenuti pieni pe r il centraggio del velivolo e quelli sulle estremità alari per compensare un problema di instabilità aeroelastica. CONTROLLO ATT=VO CG In volo : =l rifornimento in volo viene uti lizzato prevalentemente per velivoli militari o in missioni particolari . Esso avviene tramite una sonda fissa o estraibile. =l s istema a tubo rigido viene consolidato durante la guerra fredda per permettere all’aviazione americana di continuare a sorvolare i territori prossimi al suolo russo. = c accia più piccoli in genere non sono in grado di gestire una portata elev ata di combustibile e dunque utilizzano il tubo flessibile formato da una sonda , che entra in una sorta di canestro e schiaccia un sensor e che a sua volta fa partire il rifornime nto . M=SURE NELL’=MP=ANTO Misure richieste: ‣ p uscita delle pompe ⇒ fornisce indicazioni sul corretto funzionamento dell ’alimentazione dei motori , eventuali guasti delle pompe o nella linea di alimentazione provocherebbero infatti un abbassamento della pressione. ‣ Q linee di alimentazione ⇒ fornisce indicazioni sul corretto funzionamento dei motori ( ma non necessaria per indagare il funzionamento dell’impianto) ‣ V combustibile disponibile Misure di pressione: Misure di portata : All’aumentare della portata la paletta si inclina sempre di più, modificando l’apertura della luce fino all’equilibrio . Se si riesce a leggere la posizione della paletta, si può avere una misura indiretta della portata . Misure di quantità di combustibile È di importanza fondamentale conoscere la massa di combustibile presente nei serbatoi per valutare l’autonomia residua ; questa misura viene ottenuta indirettamente attraverso la misura del volume, ottenuta dal livello di combustibile nei serbatoi, corretta in funzione della temperatura. =ntegrazione Q altamente sconsigliata per accumulo errori e poiché non misura eventuali perdite dai serbatoi -> tecnica non utilizzata se non per osservare presenza di perdite . Data la forma dei serbatoi, é necessario un certo numero di sonde per poter sempre eseguire misur e del livello del combustibile. Le sonde possono essere costituite da galleggianti collegati ad una cerniera tramite un'asta, oppure in grado di traslare lungo una guida; misurando mediante un potenziometro l'inclinazione dell'asta o la posizione lungo la guida si ha una misura del livello di combustibile. Una soluzione più raffinata e frequente è quella di utilizzare sonde capacitive . Recentemente (Boeing 777) sono state sviluppate sonde ultrasoniche , che misurano il livello di combustibile in base ad un segnale riflesso dal p olo libero. Tipologie di sonde: ‣ Galleggianti con potenziometro ‣ Capacitive ‣ A ultrasuoni ( non tanto utilizzate) Salvo casi semplici, é necessario l’impiego di calcolatori per elaborare l’indicazione delle sonde . SONDE CAPAC=TAT=VE: Sono le più utilizzate , affidabili, sicure ed economiche . S ono realizzate mediante due cilindri coassiali, ognuno dei quali costituisce l'armatura di un polo di un condensatore; la capacità del condensatore dipende, oltre che dalle caratteristiche geometriche, anche dal dielettrico: tale capacità risulta quindi le gata al livello di carburante all'interno della sonda. =n genere è necessario introdurre uno smorzamento del segnale fornito dal trasduttore di livello, per evitare di rilevare sull’indicatore tutte le fluttuazioni presenti nel serbatoio. Questo si può ottenere elaborando opportunamente il segnale o rallentando la variazione di livello all’interno delle sonde, come ad esempio nel caso delle sonde capacitive, facendo entrare il combustibile nello spazio fra le due armature att raverso ficcoli fori. =n tutti i casi sopra citati si ottengono dal trasduttore delle misure di livello; quello che in realtà conta conoscere è la quantità di combustibile in volume, o meglio in massa, contenuto nel serbatoio; date le forme spesso assunte dai serbatoi la correlazione fra livello e volume non è lineare. Utilizzando le sonde capacitive è possibile, mediante opportuna lavorazione della sonda stessa, avere una distanza variabile fra le due armature e quindi costruire sonde che di ano direttamente una misura del volume. Questa tecnica è stata utilizzata, ma evidentemente costosa perché occorre costruire sonde specifiche per ogni serbatoio.Per molte forme di serbatoi un'unica sonda non è sufficiente per avere una misura del volume, perché non è possibile trovare nessun punto dove una sonda possa misurare una variazione di livello in tutto il campo di variazione del volume del combustibile. Per tutti questi casi occorre ricorrere ad un certo numero di sonde ed elaborare le informazioni da esse raccolte; con serbatoi alari è possibile avere sonde che per un certo campo di volume resti no sempre completamente bagnate o completamente asciutte. L'elaborazione del volume di combustibile residuo è stata una delle prime funzioni demandate a bordo di velivoli a calcolatori; impiegando un calcolatore digitale è inutile ricorrere a sonde sagomate in modo da dare direttamente indicazione di volume, ma è più conveniente costruire sonde semplici in grado di misurare il livello e impostare nel calcolatore una curva di taratura. Per ottenere la massa di combustibile presente occorre avere anche una misura di temperatura in modo da poter tenere conto delle variazioni di densità del combustibile, che possono essere sensibili. RETE D= D=STR=BUZ=ONE COMBUST=B=LE Gli impianti combustibile sono molto vari a seconda del numero e del tipo di motori e della posizione relativa fra serbatoi e motori. Nei velivoli moderni i motori sono normalmente motori a turbina (turbogetti o turboelica), più raramente motori alternativ i ad iniezione; in entrambi i casi il motore è dotato di una sua pompa che produce la pressione necessaria per un corretto funzionamento degli iniettori e regola la portata di combustibile per controllare la potenza erogata dal motore. L’impianto combustibile è quindi costituito dai serbatoi e da una rete di distribuzione che presenta ai motori il combustibile con valori di pressione in un campo che assicura il corretto funzionamento delle pompe del motore per tutte le possibili portate richieste dal motore in tutte le possibili condizioni di volo. Fondamentalmente la rete di distribuzione è strutturata con tante di linee di alimentazione quanti sono i motori, ogni linea è dotata di uno o più serbatoi. E’ però indispensabile integrare lo schema con l’introduzione delle linee di rifornimento, di travaso, di eventuale svuotamento rapido e di alimentazione incrociata (cross feed) per poter collegare qualsiasi serbatoio con qualsiasi motore in caso di guasti. L'impianto più semplice lo si può realizzare in monomotori con motore alternativo a carburatore, e quindi con portate di combustibile modeste (piccoli velivoli con motori a pistoni e ala alta) ; in questi casi se il serbatoio è montato in una posizione per cui viene a trovarsi in tutti gli assetti di volo ad una quota più alta del carburatore, è possibile sfruttare la gravità per l'invio del carburante. =n questo caso l'impianto sarà quindi limi tato al serbatoio, ad una valvola di esclusione che consente di isolare il serbatoio dal motore, ad un filtro e una presa di spurgo. Per potenze alte e per motori con alimentazione ad iniezione, sia alternativi che a turbina, è normalmente necessario avere nell'impianto una pompa, in alcuni casi attivata solo per regi mi del motore al di sopra di un determinato valore. Aumentando il numero dei serbatoi e dei motori l'impianto si complica per la necessità di poter alimentare qualsiasi motore con il combustibile di qualsiasi serbatoio. Questo è necessa rio per alimentare un motore anche in caso di guasto del suo sistema di alimentazione e in caso di piantata di motore per non diminuire troppo l'autonomia del velivolo e per evitare di squilibrare il velivolo mantenendo pieni i serbatoi di un'ala mentre ven gono svuotati quelli dell'altra. Nei casi più comuni si hanno, per ogni motore, un serbatoio principale ed un serbatoio alternativo. L'alimentazione dei singoli motori avviene in condizioni normali dal corrispondente serbatoio principale; tuttavia è possibile o alimentare il motore dal serbatoio alternativo o travasare il com bustibile dal serbatoio alternativo al principale. Nei velivoli con turboreattori i consumi raggiungono valori molto alti; le portate sono quindi grandi e di conseguenza sono importanti le perdite di carico nei condotti; questo rende necessaria la presenza di pompe in modo da assicurare in tutto l'impianto una pressione che permetta alla pompa del motore di funzionare. Anche se è il motore che determina la portata necessaria al momento, bisogna garantire che in tutto l’intervallo di portata richiesta la pressione all’ingresso del motore sia compresa tra un valore minimo ed uno massimo. Le pompe dovranno quindi essere tali da mantenere, per tutti i valori di portata richiesti, una pressione che sia superiore alla tensione di vapore del combustibile, ma non tr oppo elevata in modo da garantire un corretto funzionamento della pompa di iniezione del motore. Conviene che le pompe siano essere installate il più a monte possibile nell'impianto ed è molto comune avere elettropompe centrifughe immerse direttamente nei serbatoi. =n molti impianti i serbatoi principali hanno pozzetto di raccolta con valvole di non ritorno, che impediscono il riflusso del carburante nel serbatoio, e talvolta riempimento del pozzetto tramite pompe che prelevano il combustibile da varie pa rti del serbatoio, oltre che per gravità. Per i velivoli nei quali il peso massimo ammesso all'atterraggio è inferiore al peso massimo al decollo occorre prevedere dispositivi per lo scarico rapido del combustibile, in modo da consentire atterraggi di emergenza. Sulla linea di alimentazione, oltre alle valvole necessarie al stabilire i collegamenti voluti, saranno sempre presenti filtri e un valvola di shut -off; questa è una valvola montata sulla paratia antifiamma del motore che esclude in modo sicuro il collegam ento fra il motore e i serbatoi ev itando così la propagazione di fiamma nel caso di incendio del motore. Garantire intervallo pressioni min/max del combustibile, in un intervallo di portate min/max: ‣ Per gravit à: serbatoi collocati pi ù in alto rispetto ai motori (piccoli velivoli con motori a pistoni e ala alta) ‣ A pressione: utilizzo di pompe fluidodinamiche a palette o centrifughe ‣ Q determinata da richiesta del motore, variabile a seconda del regime ‣ Pompa di alimentazione deve adattarsi alla Q richiesta SCELTA DELLA POMPA Qualunque sia il tipo di motore utilizzato, è il motore stesso che in base al suo regime di funzionamento determina la portata sulla linea di alimentazione, è però necessario garantire che vi sia un corretto valore di pressione all’ingresso del motore. Par tendo dal valore esistente nel serbatoio si ha infatti un calo di pressione lungo la linea dovuto alle perdite di carico, o ccorre assicurare che lungo tutta la linea ed in particolare all’ingresso del motore la pressione abbia un valore superiore ad un min imo (al limite rappresentato dal valore di tensione di vapore), ma anche inferiore ad massimo per consentire un corretto funzionamento della pompa presente nel motore. Compito della pompa dell’impianto combustibile è quindi quello di garantire che, per qualsiasi valore di portata imposto dal motore e per qualsiasi condizione di volo (velocità, quota, temperatura, manovra,ecc.), vi sia all’entrata al motore un valore di p ressione contenuto fra un massimo e un minimo assegnati. POMPA CENTR=FUGA POMPA ASS=ALE POMPA A GETTO POMPE FLU=DOD=NAM=C:E Usate per inviare combustibile: ‣ Da un serbatoio di raccolta al propulsore ‣ Da un serbatoio all ’altro per operazioni di centraggio o avarie ‣ Da diversi punti del serbatoio al serbatoio di raccolta ‣ All ’esterno per atterraggio emergenza R=DONDANZA ‣ Almeno una pompa per motore ‣ Disponibilit à di pompe di emergenza o alimentazione incrociata, con by -pass dei sistemi in avaria ‣ Pompe azionate dai motori stessi (pistoni) o da motori elettrici (turbina) CURVE CARATTER=ST=C:E: ‣ Curve p - Q Le pompe di alimentazione impiegate negli impianti combustibile sono solitamente pompe fluidodinamiche di tipo centrifugo le quali presentano il vantaggio di adattarsi a qualsiasi va lore di portata, nell’ambito del loro campo di funzionamento. La figura rappresenta l’andamento qualitativo tipico della curva caratteristica di una pompa centrifuga ad un certo regime di rotazione. Normalmente pompe di questo tipo vengono usate sul ramo discendente della curva dove il rendimento è massimo. Per questo i mpiego il vantaggio di questo tipo di pompe è nella loro semplicità costruttiva, che le rende affidabili ed economiche e nel fatto di adattarsi a qualsiasi portata nel loro campo di funzionamento. =noltre consentono il passaggio di fluido anche se ferme. Per il p rogetto del sistema di alimentazione, occorre tener conto del fatto che le portate possono essere rilevanti e di conseguenza le perdite di carico possono assumere valori sensibili. Nella configurazione poi, spesso adottata dai velivoli commerciali, con ser batoi alari e motori in coda, le lunghezze delle tubazioni diventano di una certa consistenza e di conse guenza le perdite di carico possono diventare ancor più importanti. - p diminuisce al crescere di Q nel ramo utile della curva - Curva varia al variare di n pompa - Al variare del punto di funzionamento (sia come numero di giri che come portata) varia il rendimento della pompa - = diagrammi sono simili per tutte le tipologie di pompe - Parabola con il massimo sull’asse delle ordinate, rubinetto chiuso - m an mano che si apre il rubinetto si scende di pressione Criteri di verifica ‣ Verifica: in tutto il campo di Q richieste dal motore, la p all ’ingresso motore deve essere nel campo min/max prescritto ‣ Curve sperimentali caratteristiche fornite dal produttore ‣ Perdite di carico nella linea fra pompa e motore ‣ Normalmente pompa immersa nel serbatoio Tutti i grafici sono in funzione della portata . Nell’impianto la portata è determinata dal regime di funzionamento del motore, per ottenere il valore di pressione al suo ingresso, occorre sottrarre alla pressione in uscita dalla pompa le perdite di carico lungo la tubazione. ( pe = p engine) . La pompa deve generare p più alta di quella richiesta dal motore, a causa delle perdite di carico D=AGRAMMA D= AL=MENTAZ=ONE È possibile individuare una pompa che abbia una curva caratteristica idonea a soddisfare le esigenze di una linea di alimentazione con una costruzione come quella mostrata nella fig ura. =n essa le pressioni in ordinata sono riferite all’uscita dalla pompa e quindi ai valori limite pM=N e pMAX che si devono avere all’ingresso del motore occorre aggiungere le perdite di carico lungo la linea, funzioni del quadrato della portata. Per la pressione pp erogata dalla pompa deve quindi essere La pressione pE deve arrivare al motore con valori compresi tra il min e il max, in tutto l’intervallo di portata QE che può richidere il motore . Per soddisfare le specifiche richieste la curva caratteristica della pompa deve quindi trovarsi fra le due curve tracciate a partire da pmin e pmax per tutto il campo da Qmin a Qmax. Questa costruzione grafica può essere utile per selezionare una pompa fra varie pompe le cui curve caratteristiche siano fornite dal costruttore in forma grafica. ratteggiata, entrando e uscendo dai segmenti verticali . CROSS FEED Alimentazione incrociata Nel caso di velivoli plurimotori è prevista la possibilità di alimentazione incrociata (crossfeed), deve cioè essere possibile da qualsiasi serbatoio raggiungere qualsiasi motore ed inoltre alimentare contemporaneamente due motori in caso di avaria(di motore o serbatoio) . Nel caso di alimentazione incrociata si deve tenere conto del fatto che la portata richiesta alla pompa in condizioni di emergenza può arrivare al doppio di quella richiesta in condizioni normali di funzionamento. Dunque risulta conveniente dividere i flussi il pi ù a monte possibile, ovvero porre le valvole di cross feed in prossimità dei serbatoi . Schema caratteristico di un velivolo con il motore in coda: =n caso di avaria (es. Serbatoio 2, pompa fluidodinamica danneggiata) per alimentare entrambi i motori é sufficiente mettere una linea di alimentazione incrociata. Nel primo caso tutta la portata doppia percorre un tratto abbastanza lungo di tubo (perdite di carico quadruple, c’è il rischio che non venga soddisfatta la persistenza della curva caratteristica della pompa) . Nel secondo caso la portata viene diramata subito e vengono ripristinate le condizioni di alimentazione normale –> dove possibile si sceglie questa soluzione . TRAVASO Ps + DPp – Dpc = Ps -> DPp = Dpc -> incremento di pressione generato da pom pe = delta perdite di carico -> unico punto in cui é soddisfatta l’uguaglianza é detto punto di funzionamento del sistema . Se ci spostassimo a sinistra la pressione della pompa super erebbe di troppo le perdite di carico, causando un’accelerazione del combustibile. Viceversa spostandosi a destra si andrebbe incontro a troppe perdite di carico. L’operazione di travaso va compiuta in navigazione. Nel caso di travaso da un serbatoio ad un altro serbatoio, se i serbatoi di partenza e di arrivo sono alla stessa pressione, la portata di travaso viene determinata attraverso l’intersezione delle curve caratteristiche della pompa e della tubazione di collegamento, in tali condizioni la pompa deve infatti fornire una differenza di pressione pari alle perdite di carico sulla linea. È evidente che se la pompa utilizzata per il tra vaso è la stessa che viene utilizzata per l’alimentazione del motore, la portata di travaso non può essere molto maggiore di quella richiesta per il motore e di conseguenza i tempi di travaso sono dello stesso ordine di grandezza dell’autonomia oraria gara ntita da un serbatoio. SVUOTAMENTO SERBATO= necessità di svuotamento : ‣ A terra per ispezione e manutenzione impianto ‣ =n volo per atterraggio di emergenza: - Riduzione rischio di incendio durante atterraggio d’emergenza ( in caso di crash landing) -> se c’é guasto importante il pilota cerca di eliminare tutto il combustibile - MLW se ad esempio non ci sono guasti, ma emergenza per malore a bordo, il pilota scende a MLW e poi atterra ESEMPIO B747 Verde: linee di espulsione del combustibile Rosso : linee di alimentazione Esempio: impianto a gravità Pm = Ps – lambda*L/d *0.5*pho*(Q /A)^2 – K*Q^2 + pho*g*L Perdita = lambda*L/d *0.5*pho*(Q /A)^2 – K*Q^2 ESEMP=O ARC:=TETTURE D= =MP=ANTO COMBUST=B=LE PARTE B: SPAZIO S=STEMA PROPULS=VO SPAZ=ALE funzioni: - Ascesa lanciatore - Modifiche traiettorie - Trasferimenti orbitali - Controllo assetto PROPELLENT= Possono essere solidi, liquidi o ibridi La maggioranza dei velivoli spaziali é ancora basata su propellenti solidi . PROPELLENT= SOL=D= P=U’ COMUN= : - Al o Mg + N:4NO3 (nitrato di ammonio) - Al + N:4ClO4 ( perclorato di ammonio) - Aggiunta di cristalli di esplosivo per aumentare impulso e di leganti e altri additivi per migliorare caratteristiche meccaniche =nnesco pirotecnico o con getto di gas caldo da combustione : PROPELLENT= L=QU=D= : N2:4 si scompone con reazione molto isotermica e viene fatto espandere in un ugello -> spinta molto potente L’idrazina é instabile, pertanto viene riposta su un letto di ferro o di cobalto (catalizzatori che permettono l’innesco del processi) per ottenere una combustione. L’idrazina é un composto chimico molto corrosivo, volatile e tossico. SOL=D= E L=QU=D= A CONFRONTO Svantaggio del propellente solido: gas espulsi dall’ugello sono ricchi di particelle solide che portano all’abrasione dell’ugello Svantaggio del propellente liquido: materiali dei contenitori sono infragiliti dalle basse temperature, comportando così un elevato rischio di danneggiamento (Motore di apogeo viene utilizzato per i trasferimenti orbitali ) S=STEM= D= PROPULS=ONE ELETTR=C= Propulsione elettrotermica : ‣ Getto di gas sovrariscaldato da archi elettrici o resistenze di tungsteno ed accelerato attraverso un ugello (< 10 N) ‣ :2, CO2, C:4, N2:4, N:3, N2, :e and Ar Propulsione elettrostatica a ioni : ‣ Getto di gas ionizzato da bombardamento di elettroni in una camera a confinamento magnetico, poi accelerato da campo statico di 1 – 10 kV (< 1 N) ‣ Xe,Kr, Cs, :g e Ar (alto peso molecolare) Produce una s pinta piccola, ma la quantità di combustibile necessaria é altrettanto piccola --> risulta dunque efficiente per controllo assetto e aggiustamenti orbitali Di utilizzo meno frequente rispetto ai precedenti ‣ Gas freddi: per piccoli trasferimenti orbitali e controllo assetto ‣ =bridi: in fase di studio avanzato ‣ Nucleari a fissione, per scaldare gas propellenti oppure per generare potenza che fa funzionare propulsori elettrotermici o a ioni ‣ Vele solari (spiegate verso il sole, sfruttano la pressione solare, materiale leggero)